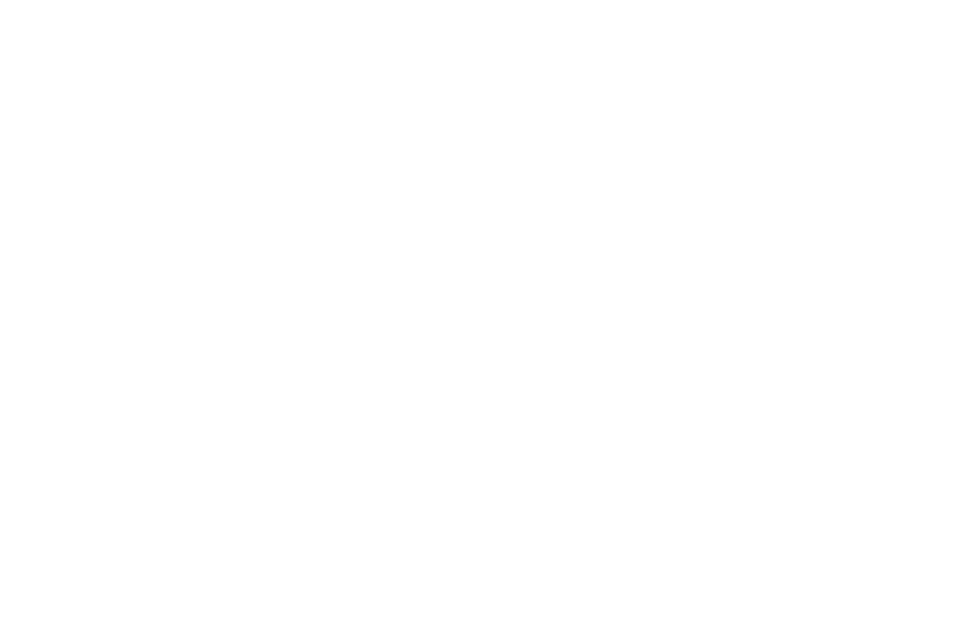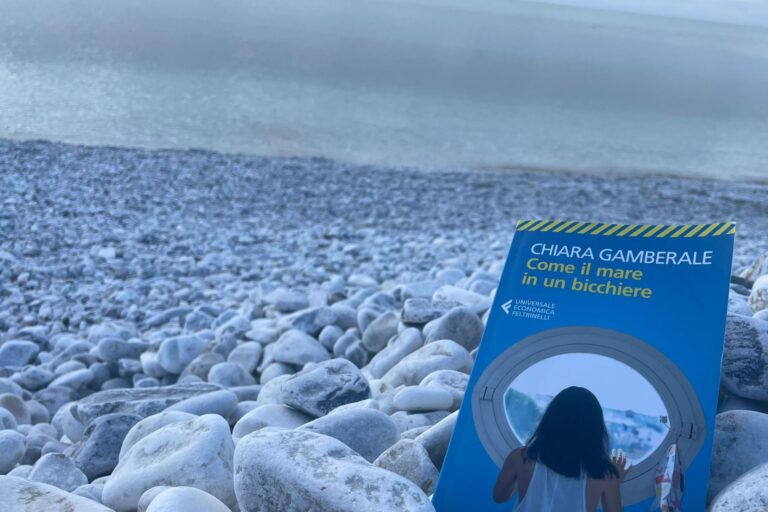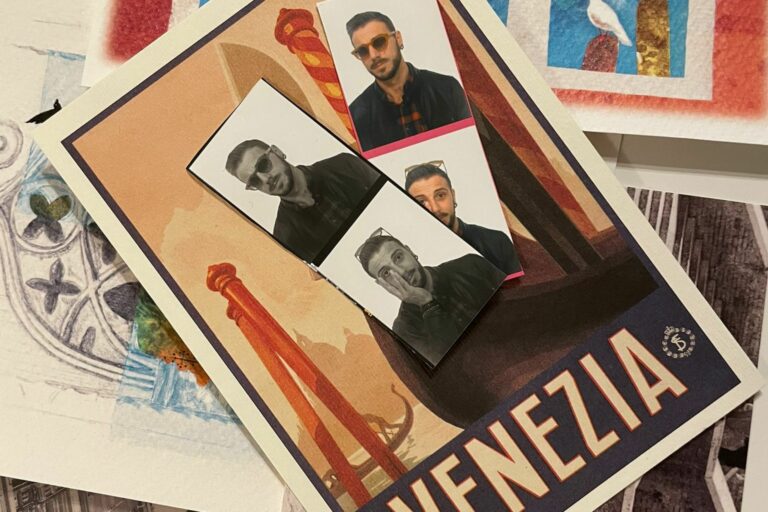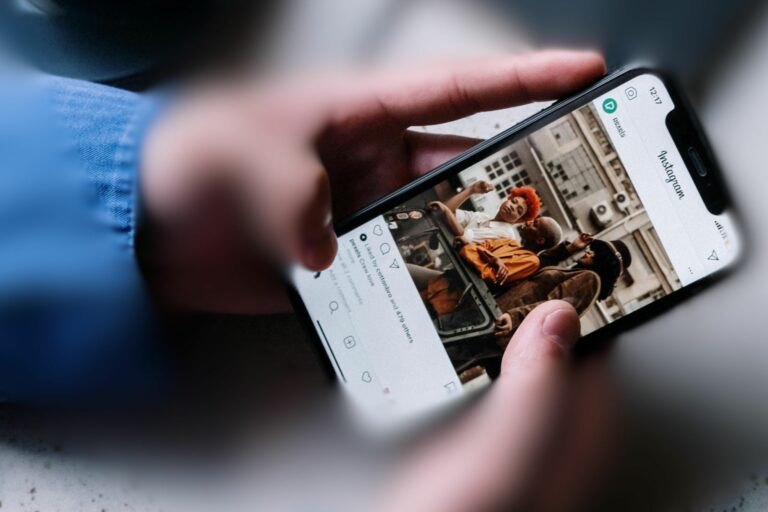Per motivazioni, forse culturali, siamo portati a dare al dubbio una connotazione negativa. La sicurezza è generalmente associata a una buona performance, all’efficienza, al raggiungimento di obiettivi. Per anni, direi sicuramente troppi, anche per me il dubbio era un qualcosa di negativo. I dubbi erano qualcosa da risolvere, da far sparire, ma soprattutto da far sparire in fretta. Che grosso errore pensarla così: il dubbio, invece, è il vero motore di crescita, più delle sicurezze. Le sicurezze ci rendono immobili, il dubbio ci fa muovere.
Il dubbio di non essere abbastanza
Il mio cervello ha convissuto e convive con un tarlo: quello di non essere mai abbastanza, di non sapere mai abbastanza, di non fare mai abbastanza. Fare costantemente i conti con questo tarlo è sempre stato devastante. Quando non ne potevo più di essere stanco e affaticato da questa cosa, ho scelto di iniziare un percorso di psicoterapia. Ben presto, mi si è parata davanti una cosa, per me, rivoluzionaria. Il dubbio è tutt’altro che negativo.
Quello che ho raggiunto, in termini di studio, in termini lavorativi lavorativi e personali, l’ho raggiunto perché non mi sentivo abbastanza. Mi spiego meglio: se io avessi percepito di essere arrivato, ergo di essere abbastanza. Sembra assurdo vero? Ma mii sarei impegnato molto meno nel fare le cose. Invece, il dubbio di non fare a sufficienza, era quel motore che mi teneva sulla sedia a studiare, studiare e studiare. Già qui la questione inizierà a sembrarvi più chiara: il dubbio è un motore che ci spinge a fare sempre quel passo in più, a leggere un nuovo libro, a fare cose nuove; senza questa sensazione di vuoto saremmo fermi.Tutto, come al solito, si gioca sugli equilibri, sulle quantità: esiste un eccesso di “non abbastanza”, un eccesso di dubbi, che diventa deleterio per chi lo sente, diventa pericoloso perché ci fa sentire sempre insoddisfatti e mai parchi di quello che facciamo. Non va però bene l’eccesso opposto, ovvero, quella sicurezza che ci farebbe restare piantati senza una crescita. Né troppo, né troppo poco. Ci serve la giusta quantità di dubbi.
Elogio dell’ignoranza e dell’errore
Una seduta di psicoterapia dietro l’altra, ho iniziato a volere bene ai miei dubbi, a coltivarli e a cercare di sviluppare una vera e propria cultura del dubbio: un dubbio sano, un dubbio costruttivo, un dubbio che fa evolvere e crescere. Recentemente ho letto il libro “Elogio dell’ignoranza e dell’errore” di Gianrico Carofiglio, e in questo libro ho trovato questo concetto di dubbio, espresso in maniera perfetta.
Il secondo capitolo del libro si chiama “Esperti”. Si apre con un elenco di previsioni terribilmente sbagliate fatte da alcune persone, ad esempio Albert Einstein che sosteneva che non si sarebbe mai potuta produrre energia atomica; o l’inventore della telefonia mobile che aveva affermato che questo settore avrebbe avuto vita breve. Tutte le previsioni presentate sono state smentite nei fatti, e io aggiungerei smentite brutalmente.
Il capitolo prosegue con lo studio dello psicologo Philip Teclok. Questo ha analizzato 28.000 pronostici, fatti da 284 esperti in vari campi. Il risultato è che l’accuratezza dei pronostici era inferiore a quella che avrebbe un algoritmo elementare. Lo studio pare suggerire anche un’altra cosa: più l’esperto che ha formulato il pronostico è famoso, più il pronostico è inaccurato.
La ricerca ha, ovviamente, generato polemiche e discussioni, ma al di là della sua validità scientifica, ci suggerisce qualcosa su cui riflettere.
La sicurezza rischia di immobilizzare
Fermo restando l’importanza delle competenze e senza, in alcun modo, mettere in discussione il valore degli esperti, pare che molti di questi sbaglino le previsioni per narcisismo. Più qualcuno è convinto di sé stesso, delle proprie opinioni e delle proprie visioni delle cose, più sbaglia e più sminuisce visioni e opinioni alternative. Cosa manca quindi? Manca il dubbio.
Per fare una buona previsione, abbiamo una conditio sine qua non imprescindibile: la capacità di osservarsi, mettersi in discussione, accettare i propri errori, accettare di mettere in discussione le proprie conclusioni e difenderle solo se inconfutabili. Per fare tutto ciò è necessario un grosso prerequisito: la capacità di ascoltare.
Tra le soluzioni per rendere meno preponderante l’ego, Carofiglio, suggerisce proprio il coltivare il dubbio costruttivo.
Coltivare il dubbio costruttivo
Per poter crescere davvero è necessario abituarsi, con metodo, a porsi e a porre domande, quindi a far venire e farsi venire dubbi. La domanda, se ben posta, crea quello stato di tensione, quell’insicurezza che altro non è che un dubbio che poi, senza fretta, va sciolto. Carofiglio fa poi la distinzione tra domande convergenti e divergenti. Quelle convergenti sono le domande che ammettono una sola risposta, quella giusta, quindi per natura sono domande chiuse, una domanda rigida.
Le domande divergenti, invece, sono quelle domande che ammettono tante risposte, sono domande aperte che favoriscono nuovo sapere, nuovi ragionamenti, nuovi modi di fare. Quindi, perché funzionano le domande divergenti? Torniamo sempre lì: perché generano dubbi.
Da quanto detto finora, ne deriva che se vogliamo crescere davvero, è necessario porre e porsi domande divergenti: cosa può spingermi a cambiare idea? Cosa potrebbe convincermi che la mia conclusione è sbagliata? E nel risponderci, dobbiamo fare attenzione, a non ricercare attentamente sono quello che conferma la nostra idea. Dobbiamo sforzarci di trovare in qualcosa che la metta in discussione.
Conclusioni
Pensare che il dubbio sia un qualcosa di negativo è veramente pericoloso. Le sicurezze lasciano poco spazio alle alternative, le sicurezze sono chiuse, quasi bastano a loro stesse. Farsi domande, non sentirsi arrivati, non fermarsi a quello che si ha, non bastarsi, sono tutte spinte fondamentali per fare un passo in avanti.
Spesse volte siamo di fronte a persone sicure che ostentano grandissima sicurezza. Senza volermi sostituire a nessuno psicologo, spesso, è proprio una grande insicurezza che fa sì che le persone all’esterno mostrino questa finta sicurezza. Per cui dov’è la questione? Dipende tutto da come gestiamo queste insicurezze: vogliamo che siano un motore di immobilismo? Oppure vogliamo accoglierle e farle diventare un motore di crescita? Beh, io sceglierei sempre il secondo caso.